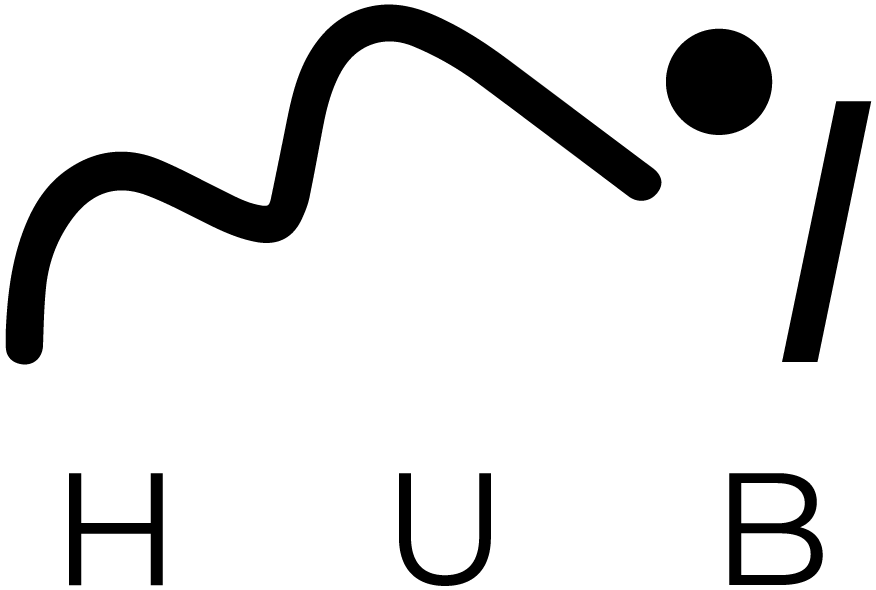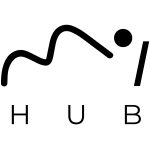Polo e Ralph Lauren sono due termini che si richiamano vicendevolmente in modo pressoché automatico e, unendosi, formano il nome della linea di prêt-à-porter più conosciuta del designer statunitense.
Per consolidare questo legame inscindibile, appena giunto al venerando traguardo dei cinquant’anni tondi, è arrivato da poco il libro Ralph Lauren’s Polo Shirt (Rizzoli International), consacrato proprio al capo d’abbigliamento che, in quanto sintesi tra la formalità della camicia e la basilarità della maglietta, incarna l’essenza stessa del brand, un american style codificato da un signore che, a 82 anni, dirige con mano sicura una multinazionale da 4,4 miliardi di ricavi. L’ impero RL, il cui asse portante sta proprio nella maglia in oggetto, se è vero, come si legge nel primo capitolo del volume (un’antologia della stessa, celebrata attraverso fotografie, aneddoti, ricordi personali e altri contenuti esclusivi) «rappresenta ciò che Mickey Mouse è per la Disney o l’Empire State Building per New York».
Un’icona, per dirla in breve, che ha contribuito a scrivere pagine memorabili della storia della griffe, sebbene non sia una novità ascrivibile a Mr. Lauren.
L’origine dovrebbe essere in effetti nel XIX secolo, quando fu introdotta in Occidente dai soldati britannici di stanza in India, che l’avevano vista addosso ai giocatori locali di polo, e importarono nel Vecchio Continente sia l’indumento che lo sport omonimo. Il presidente della Brooks Brothers John E. Brooks, a sua volta, dopo averla notata in Inghilterra, la commercializzò oltreoceano, replicandone il colletto abbottonato anche sulle camicie button-down, appunto. Sulla sponda opposta dell’Atlantico, negli anni Venti, Jean René Lacoste ne faceva la divisa d’elezione dei tennisti, non prima di averne accorciato le maniche, cucendola inoltre con un cotone fresco e leggero, il piqué.
Pur non avendola inventata, lo stilista newyorchese intuisce che la maglia è la base perfetta per edificare quella sorta di via americana al ben vestire che ha in mente da quando, nel 1968, esordisce con una collezione maschile completa. Il suo è infatti un casualwear ammantato di sofisticatezza, nel quale usi e costumi dei wasp (white anglo-saxon protestant, sostanzialmente la buona borghesia, che studia negli atenei della Ivy League, pratica sport elitari, trascorre le vacanze nelle cittadine à la page sulle coste del New England) si saldano alla fascinazione del nostro per la classe inscalfibile dei divi della vecchia Hollywood (dal venerato Cary Grant, di cui impara a memoria ogni outfit, a Gary Cooper), per il mito della frontiera, per gli oggetti dalla patina vissuta, che abbiano una storia da scoprire.
La polo del 1972, insomma, è la logica conseguenza di un racconto stilistico preciso e dettagliato: sportiva ma con juicio, strutturata pur senza ingessature, adatta alle aule dei college come ai weekend fuori città, priva di orpelli ad eccezione del provvidenziale logo col giocatore a cavallo, piazzato sul lato sinistro del petto (introdotto giusto l’anno prima sui polsini della camiceria femminile, riscuoterà un successo straordinario, finendo con l’identificare il marchio tout court). Altre caratteristiche sono il tessuto, puro cotone interlock, la vestibilità regolare, sagomata quanto basta, le spalle leggermente scese, l’orlo posteriore allungato, il collo a costine, chiuso da due bottoni. Nel giro di qualche anno, poi, si passa alla modalità “tuttifrutti”: aumenta il numero di nuance disponibili, 17 e perlopiù pastellate; lo slogan che accompagna il lancio promette inoltre che il modello «migliora con l’età», connotandolo perciò subito come un capo timeless, avulso dal ciclo continuo delle mode. Nel 2017, a coronamento dello status ormai acquisito nell’immaginario comune, arriva l’inclusione della polo nella rosa di memorabilia esposti alla mostra Items: Is Fashion Modern? al MoMa, preludio all’ingresso nella collezione permanente del museo.